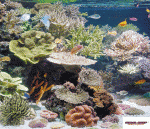L’età del ferro, secondo quanto scritto nella storia, ebbe inizio circa 500 anni prima di Cristo. I forni di fusione di allora producevano una massa pastosa. Nel corso dei secoli questo processo fu perfezionato, ma fu soltanto verso la metà del 19° secolo che si riuscì a portare alla fusione il ferro. Solamente in quel momento fu possibile produrre le leghe d’acciaio. Ma che cos’è esattamente l’acciaio? Molti anni fa ho appreso: “L’acciaio è tutto il ferro lavorato nelle fucine. Questa caratteristica dipende dalla quantità di carbonio presente nel metallo”. Questa affermazione è corretta ancora oggi. Attualmente però, si dispone di un acciaio particolarmente adatto a quasi ogni tipo di applicazione. È certamente nota a tutti la definizione “INOX”, che sta per acciaio “INOssidabile”. Questo materiale viene impiegato ad esempio per la produzione delle posate. Si potrebbe pensare quindi che questo tipo di acciaio non arrugginisca, o perlomeno la sua denominazione non lascia  supporre altro. Si tratta però di un errore! Se si puliscono le posate nella lavastoviglie, si riscontreranno di tanto in tanto delle macchie color marrone chiaro fino a nero: la ruggine! E tutto questo con l’INOX. Un altro esempio: i primi sommergibili delle marine furono costruiti con dell’acciaio “resistente all’acqua marina”. Tuttavia, arrugginivano più rapidamente di quanto riuscissero a navigare, e si rese allora necessario dotarli di un rivestimento di gomma. In ogni caso, la lista di questi esempi di ruggine, relativa ad acciaio che “non dovrebbe arrugginire” in acqua marina, potrebbe continuare a piacimento.
supporre altro. Si tratta però di un errore! Se si puliscono le posate nella lavastoviglie, si riscontreranno di tanto in tanto delle macchie color marrone chiaro fino a nero: la ruggine! E tutto questo con l’INOX. Un altro esempio: i primi sommergibili delle marine furono costruiti con dell’acciaio “resistente all’acqua marina”. Tuttavia, arrugginivano più rapidamente di quanto riuscissero a navigare, e si rese allora necessario dotarli di un rivestimento di gomma. In ogni caso, la lista di questi esempi di ruggine, relativa ad acciaio che “non dovrebbe arrugginire” in acqua marina, potrebbe continuare a piacimento.
Ruggine!

Queste due rocce sono state importate con incrostazioni coralline. In acquario iniziarono però a creare problemi. Dopo un più attento esame, hanno rivelato un forte contenuto di ferro.
Foto: D. Knop
“Ruggine” è la definizione popolare per il prodotto di ossidazione del ferro (Fe) e naturalmente anche delle sue leghe. Forma un complicato composto (FeOOH), che può contenere anche altri cationi (ad esempio cloruro, fluoruro e simili). Dato che la ruggine non aderisce sulla superficie del ferro non si può sovrapporre alcuna protezione ossidativa, come accade nel caso del rame (Patina) o del piombo. Con l’idrogeno fosfato (convertitore di ruggine), si formano dei fosfati di ferro difficilmente scomponibili che hanno un effetto protettivo (passivo). Riducono nuovamente la ruggine, rilasciando un elemento passivo come lo zinco. In particolare per via dell’impurità (non stechiometrico) della ruggine e della struttura poco resistente, questi metodi sono spesso poco efficaci. Anche nel campo della realizzazione di apparecchiature tecniche, si utilizzano acciai diversi, quelli di tipo V, principalmente V2-A e V4-A. Questi due acciai nobili sono piuttosto resistenti agli acidi e alle basi. In aggiunta, si riesce a lavorarli con relativa facilità, una caratteristica non attribuibile a tutte le tipologie di acciaio. Alcune sono alquanto fragili, rompendosi con una certa facilità. Questi acciai di tipo V fanno parte della categoria degli “inossidabili”. L’inossidabilità si ottiene attraverso la lega (fondere insieme, miscelare) con diversi additivi. Il tipo V4-A contiene ad esempio il 18 % di cromo, il 10 % di nickel, il 2,5 % di molibdeno e ridotte quantità di manganese. Altri additivi per incrementare la resistenza alla corrosione sono il tungsteno, il vanadio, il silicio ed il titanio. Queste aggiunte, per via del loro prezzo in alcuni casi estremamente alto, rendono tali acciai particolarmente cari. Ciò non significa ad ogni modo, che non tendano ad arrugginire, o meglio ad ossidarsi. Se si lasciano dei fogli grezzi di acciaio V all’aria aperta, col tempo assumeranno una colorazione marrone: si arrugginiscono. Inoltre, possono verificarsi danni per via di altri ossidanti, che frequentemente non vengono a prima vista riconosciuti. Per la costruzione di diverse apparecchiature nel campo della biochimica, vengono impiegati essenzialmente acciai di tipo V4-A. Per aumentare la loro resistenza subiscono normalmente una elettro pulitura. Durante tale procedimento, la superficie in frazioni di millimetro viene sciolta, ed i pori e le irregolarità, presenti in una grandezza microscopica, vengono ridotti o eliminati. Si crea una superficie liscia e altamente riflettente. In poche parole, si riduce la superficie aggredibile dall’ossidazione, diminuendo così il rischio della ruggine.
Prove di corrosione
Qualche anno fa ho svolto delle prove di corrosione con delle lastre metalliche di tipo V2-A e V4-A, poste in una soluzione contenente sale da cucina ad una temperatura di 30° C. La concentrazione salina con circa il 3%, era sensibilmente più elevata di quella di un acquario marino, ma il resto delle condizioni erano molto simili e il liquido veniva anche gassificato con aria, per rendere disponibile l’ossigeno. Successivamente le lastre metalliche furono sottoposte ad un esame metallurgico. Alla loro rimozione non erano più riflettenti come prima, si mostravano al contrario opache. Il controllo rivelò una forte corrosione a livello microscopico, che aveva prodotto degli avvallamenti circondati da fratture stelliformi. Lungo i bordi di taglio delle lastre, questi danneggiamenti erano particolarmente rilevanti. Nei campioni saldati si mostrarono, in particolare nei bordi dei punti di congiungimento, piccolissime incavature. Un’analisi della soluzione rivelò tracce di manganese, molibdeno, e senza sorpresa, di ferro. Sorprendentemente il cromo indurente non era stato estratto. Questi due acciai (V2-A e V4-A) non sono quindi resistenti al cloruro! Ma che cosa c’entra con l’acquario? Ricordiamoci delle vasche di molti anni fa, che venivano realizzate con cornici di ferro. Generalmente si trattava di acciaio da costruzione (in prevalenza “St3700”). Questo acciaio prima di montare i vetri, veniva più volte trattato con ossido di piombo e con una buona vernice all’olio. Tuttavia la cornice si arrugginiva ugualmente. Per la coltivazione delle piante acquatiche sembrava una cosa positiva, ma non certo per la vasca. In questo senso, l’impiego del tipo V2-A si rivelò un evidente ma dispendioso progresso, fino a quando non venne sostituito dagli acquari sigillati con il silicone. Oggi i nostri acquari marini sono praticamente privi di metalli. Soltanto gli alberini di alcune pompe sono ancora di acciaio. In questo caso però si utilizza un materiale altamente pregiato, resistente al cloruro e addirittura cromato. La maggior parte delle assi di rotazione per pompe ad immersione sono oggi comunque realizzate in materiale ceramico.
Segue parte 2